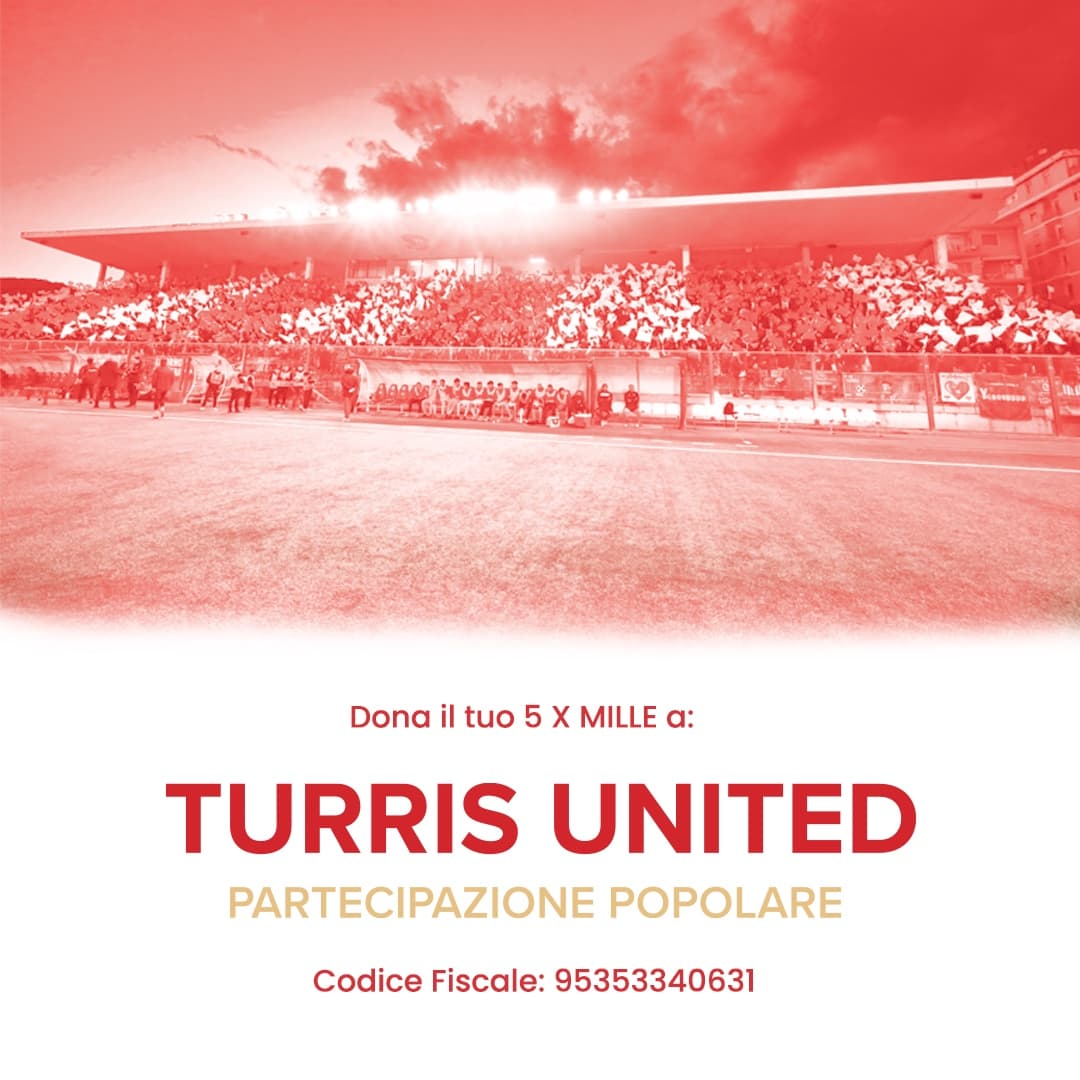Sul ponte di un traghetto che sa di sale, gasolio e insonnia, c’è una ragazza.
Sta albeggiando e lei è immobile, elegante nella sua stanchezza, con il corpo appoggiato alla ringhiera fredda e l’anima che fuma più della sigaretta, l’ennesima, che tiene tra le dita.
Davanti a lei la terraferma, il porto di Palermo, si avvicina lentamente, solenne, inevitabile. Lei la guarda con nostalgia. Nostalgia, un termine particolarmente delicato. Nóstos (ritorno a casa) e álgos (dolore): la sofferenza di chi sa da dove viene ma non è più certa di dove stia andando.
Ha sempre amato la scrittura, visceralmente, ostinatamente. Dopo due lauree pensava di aver messo ordine, di aver dato nomi precisi alle cose, alle ambizioni, persino ai sogni. E invece no.
Da un po’ ha smarrito se stessa.
Demoni silenziosi e famelici le consumano lo stomaco e la testa, come tarli notturni, come pensieri circolari. Quella notte, come tante altre, l’ha passata in bianco. Occhi aperti, cuore acceso, mente in fuga. Scrivere le ha insegnato a osservare tutto, tranne
sé stessa.
A centinaia di chilometri di distanza, ci sono tre Transit neri. Uno di essi è particolarmente rumoroso e sovraffollato.
Al volante c’è quello più intelligente. Gli altri dicono che è lui quello che comanda.
La settimana la passa con la schiena piegata dal lavoro, inchiodata a una disciplina ferrea, quasi monastica. È preciso, chirurgico, ossessivo. Il controllo per lui non è una virtù: è una necessità fisiologica.
Sta viaggiando sulla Salerno–Reggio Calabria. Secondo i suoi calcoli — meticolosi, maniacali — a quell’ora dovrebbero essere già a Cosenza. Invece no.
Sono poco dopo Battipaglia.
Colpa della notte brava di otto dei nove occupanti del furgone: vomito, pipì, soste infinite, dignità perse lungo l’asfalto. Rumori di bottiglie di birra vuote che ad ogni curva fanno su e giù per il 9 posti.
Sono in una piazzola di sosta. La quarta da quando hanno messo le gomme su strada.
È nervoso, parecchio. Abbassa il finestrino con gesto secco, rabbioso, e richiama quello alla sua destra, intento a trafficare con la cerniera dei pantaloni.
Quello doveva essere il suo scudiero.
E invece è il capobanda dei monelli, l’anima anarchica del gruppo, quello che non vuole sentire nello stereo Gaber e De André, che rifugge la poesia civile (e quindi la sabota) e preferisce un più rustico e bucolico Natale Galletta.
Ordine contro caos. Strategia contro istinto.
Nervi tesi e chilometri sbagliati.
Saliamo ancora un altro po’ in direzione nord.
Aeroporto di Capodichino. Controlli di sicurezza. Bisogna “spogliarsi”.
Il volo è uno dei primi del mattino, di quelli economici presi da chi è sempre stato avanti, lungimirante, quando ancora non esistevano smartphone a salvarti la memoria e la convenienza.
È fresco, sereno. La sera prima l’ha passata con la sua amatissima fidanzata, pizza in piazzetta, semplicità perfetta.
Con l’atteggiamento guascone e ironico che lo distingue da sempre, si toglie il cappello da pescatore, la cintura (con la fibbia doppia che non si sa mai), gli occhiali da sole, la catenina di oro regalata dalla nonna e poggia tutto nella vaschetta. Guarda
l’addetto ai controlli e scherza:
«Vedi di non farmi togliere anche la camicia (lacoste)… io sono come il coccodrillo che ci sta sopra.»
«Appaio all’improvviso da sott’acqua e do i morsi.» Risate dei tre amici che sono con
lui.
L’anno prima però lo ha marchiato dentro: il terremoto de L’Aquila, vissuto a pochi chilometri di distanza, durante un corso di formazione per il lavoro da impiegato amministrativo che ha ottenuto da poco. Ancora sente la terra tremare sotto i piedi, ancora si porta addosso quel carico muto di dolore collettivo.
Qualche mese dopo, un’altra catastrofe dell’anima.
Il 28 agosto 2009 Liam e Noel Gallagher sciolgono gli Oasis in una notte francese e turbolenta, tra chitarre fracassate in testa e un pubblico rimasto senza Live Forever e Don’t Look Back in Anger. Colpi durissimi.
Ma lui reagisce. L’estate del 2010 è bellissima, luminosa, quasi salvifica.
Con un gruppo di amici storici, porta il rock’n roll nella sua città. Nasce un evento.
Se ne parlerà per anni.
Gli Dei salvino la musica, il football e le Adidas Stan Smith bianche.
Cosa hanno in comune queste tre persone così diverse, a parte il fatto di essere sveglie alle 5:01 del mattino del 5 settembre 2010?
Nulla, probabilmente.
E invece no. Qualcosa ce l’hanno.
Sono in viaggio, i nostri tre Ulisse (il tre è un numero che tornerà spesso in questo racconto).
In rotta verso Itaca.
La loro Itaca è una casa fatta di idee, di emozioni, di appartenenza.
Quel giorno si invocano le muse del pallone.
Si va a Mazara del Vallo.
Comincia la Turris.
La prima arriva, insieme ad un istrionico gruppo di compagni di viaggio, a Palermo all’alba. Un’alba stanca, salmastra, appiccicosa, di quelle che sanno di promesse mantenute a metà.
Sbarcano dalla Tirrenia come reduci di una guerra combattuta contro il sonno: visi sgualciti, disfatti, eroicamente segnati dalla notte passata sulle poltrone rigide, ostili, progettate da qualcuno che odiava profondamente l’umanità.
Tutti meno uno.
Uno più furbo, più scaltro, più bendisposto dagli dei del mare: ha “trovato” una cabina della nave aperta. Per caso, certo. Per destino, soprattutto. Del resto, quando fai il marittimo di mestiere e conosci per nome mezzo equipaggio, la fortuna smette di
essere fortuna e diventa consuetudine.
Palermo li accoglie con il suo caos barocco, sudato, teatrale. Ballarò, Vucciria, Capo: mercati urlanti, colorati, profumati, dove il pesce ti guarda ancora negli occhi e la frutta sembra appena colta da un giardino mitologico.
Mangiano, ridono, camminano storti, ancora in bilico tra nave e terra, tra veglia e sonno.
Poi la strada verso Mazara.
Si passa da Trapani, che non è solo una città ma una parentela.
Vent’anni di amicizia tra le due città del corallo, una fratellanza antica. L’accoglienza è quella che ti frega: cannoli esagerati, brioche al pistacchio blasfeme, zuccherate al punto giusto per diventare una condanna. Saluti, baci, pacche sulle spalle.
Quell’ incontro sarà la loro dannazione. E loro non lo sanno..
Il secondo viaggio è tutto un altro poema.
Qui non c’è poesia, c’è resistenza.
La carovana dei tre transit è sempre più sgangherata, uomini ammassati come in un’arca postmoderna, con il tempo che scappa e la sfortuna che morde.
Soste di emergenza prostatica — vere, necessarie, umanissime — e poi le avarie.
Due. Distinte. Crudeli.
La meccanica come divinità ostile.
Arrivano a Villa San Giovanni a mezzogiorno inoltrato, inermi, sudati, in ritardo, con la partita alle 16 che incombe come una sentenza.
Imbarchi pieni, folla nervosa, e tre Transit di una tifoseria siciliana diretti in Calabria.
Non c’è tempo per capire chi siano. Né per fare pugilato, che pure sarebbe nella tradizione.
Adesso no.
Adesso bisogna puntare dritti verso la Turris.
Testa bassa. Acceleratore giù.
Il terzo, invece, è l’Ulisse rilassato, quello che ha capito tutto — o forse niente.
Aereoporto Falcone e Borsellino, atterra in tutta tranquillità
Auto a noleggio all’interno dell’aereoporto. Nel 2010. Roba da visionari.
Organizzato è una parola grossa: mani in tasca, bavero alzato, sguardo fatalista, ironico, disilluso. A quello che viene, viene.
Direzione spiaggia di Marausa. Mare cristallino, sfacciato, perfetto. Caldo africano, e quella Sicilia estiva che ti entra nelle ossa.
Ma il vero spettacolo sono i dialoghi.
Ore di parole inutili e fondamentali.
Il pesce di Torre del Greco contro quello di Terracina. I gamberi di Ischia — superiori, sempre — contro quelli di Mazara, che poi “a Mazara non li pescano nemmeno”, li prendono chissà dove e “lì li congelano soltanto”, e lo spacciano per
pesce buono.
Classifiche infami sugli amici che “marcano di più a peste”.
Sfottò ossessivi, crudeli, amorevoli verso quello che sta sotto il pacchero della fidanzata, scomparso dai radar.
E poi gli scherzi con l’amico di sempre, quello del lenzuolo rubato in Grecia e trasformato in pezza da stadio: folklore e crimini minori.
Discorsi su politica e calcio. Sono sempre insieme, inseparabili. Mai banali.
Ore 16:00.
Siamo a Itaca?
No.
È un miraggio.
Il Nino Vaccara di Mazara del Vallo è un inferno gialloblù, rovente, ostile.
Grotta dei Ciclopi. Fame di corallini, colpevoli di essere amici dei trapanesi.
Imperdonabile.
Duemila voci cantano contro. Non cordialmente.
I nostri eroi sulle gradinate e in campo sembrano svuotati, schiacciati dal caldo e dall’ambiente.
La partita si mette subito male, ovviamente.
1-0. Gol loro sotto il settore ospiti e si va all’intervallo così.
“Comincia bene sto campionato”, dice qualcuno. Ma c’è il secondo tempo.
E infatti.
1-1 quasi subito.
Poi i padroni di casa restano incredibilmente in dieci.
Ribaltamento. Dominio ospite.
Solo che il loro portiere è Circe: strega, beffarda, indemoniata. Para tutto. Sfotte come Grobbelaar del Liverpool contro la Roma nella finale di Coppa dei Campioni.
A cinque dalla fine, l’incantesimo: i corallini diventano porci.
2-1.
Siamo sempre la Turris. Pensieri neri, stanchezza cosmica. “Chi me l’ha fatto fare”, “chi lo dice a mia moglie”.
Poi l’astuzia.
Il cavallo di Troia.
Palla dalla metà campo sporca, sbilenca, apparentemente innocua. Tre rimbalzi.
Sinistro.
Saetta di Zeus.
Saetta di Zeus.
Saetta di Zeus
2-2. Palla nell’angolino più lontano.
Resurrezione dall’Ade.
Canti, urla, lacrime sempre accompagnate dal ritmo incessante del sole che cade sulle pelli nude dei nostri: oggi si soffre così.
E quando i Proci sembrano resistere, i nostri Ulisse scendono in campo.
Mezza rovesciata.
2-3.
La Maga Circe è a terra, con la testa bassa. L’incantesimo si è spezzato
Infarto. Ancora lacrime, stavolta copiose. Mani nei capelli.
Itaca.
Ma ora bisogna scappare. Bisogna andare da Penelope, bisogna navigare dritti verso la libertà.
I Tifosi di casa incazzati, feriti, rumorosi.
Scelta geniale: uscire in mezzo a loro.
Occhi chiusi.
Vele della speranza spiegate.
Si esce miracolosamente vivi.
Il ritorno è un epilogo dolce per i nostri Ulisse.
Nave Palermo–Napoli.
La prima, con il gruppo di amici, con il biglietto regolarmente acquistato
Il secondo, che non riuscirebbe mai a fare lo stesso viaggio di ritorno su strada, si aggrega con il resto della carovana, rigorosamente imbucata per ragioni di opportunità economica, nascosta sotto gli zaini e nei cofani.
Il terzo ha perso l’aereo, come sempre, e quindi la nave è una scelta obbligata.
La Tirrenia è un tripudio biancorosso.
Uniti. Bevono e cantano, sono ad Itaca. Sono felici.
È iniziata la Turris nel modo migliore.
E allora la chiosa è semplice, necessaria, definitiva:
lo spirito corallino non è una vittoria, è un viaggio.
È esserci, sempre.
Insieme.
Per sempre.
GALLERIA